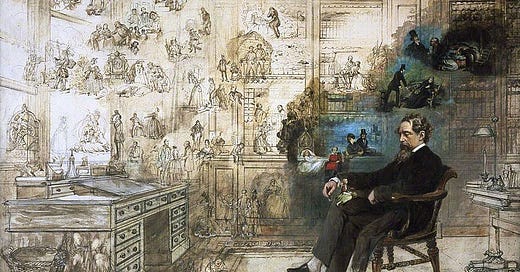Rivelazione, riflesso, voragine
Un editoriale, un manifesto, una speranza - perché La letteratura deve rivelare, riflettere e, riflettendo, dare le vertigini
L’influenza che un romanzo riesce ad avere sulla formazione di una persona è un fatto straordinario ed oscuro. Alcune opere si sfogliano sì per diletto, per noia, per curiosità – eppure, quando si ripongono nello scaffale, una volta terminate, si ha l’impressione che il gesto sia stato insignificante. Nulla, in realtà, è stato riposto, niente è finito, ma, a guardar bene, tutto sta per cominciare.
Come può la letteratura rivelarci ciò che di noi stessi non sospettiamo neppure di sapere? Non è facile accettare che una finzione – perché questo la letteratura è – ci insegni qualcosa che, incredibilmente, ci riguarda. Perché la più grande verità della letteratura è proprio questa: ci riguarda. E spaventa, non c’è dubbio, pensare che un mucchio di carta che nulla ha a che fare con noi, sappia, infine, più d’un amico, di un fratello o di una madre, parlare la nostra lingua – e dialogare con noi, di noi.
Si sentirà dire che la letteratura è la più grande indagatrice dell’Essere Umano. La sentenza, per quanto suadente, è fuorviante, perché la letteratura esplora, sì, e svela, ma nulla che non sia in primis singolare. Non dice niente, in generale, dell’uomo o della donna – non è una statistica. La letteratura è anzitutto un rapporto, una relazione, e non esiste niente di simile ad una relazione in generale. Un rapporto si ha invero solo nel particolare, mai nell’universale, ed è per questa ragione che la letteratura non può rivelare nulla, in realtà, dell’animo umano, ma può dire tanto, o fin troppo, del tuo animo, della tua umanità. L’opera letteraria compie il suo miracolo solo entro i confini di una dinamica relazionale in cui si è chiamati a vivere in prima persona. In alternativa, l’opera rimane semplicemente ciò che è, vale a dire un mucchio di carta straccia, buonissima, in questo caso, a raddrizzare un tavolo traballante.
“It is the spectator, and not life, that art really mirrors” – è il lettore, e non la vita, che l’arte rispecchia veramente – ci ricorda Oscar Wilde nella preface. Si vuole aggiungere, a tal proposito, che la Letteratura non solo rispecchia, ma rispecchia sempre, e difatti, nel caso ci capitasse di vedere Cristo si è fermato ad Eboli sotto la gamba d’un tavolo, si avrebbe in tal caso un’immagine oltremodo nitida del suo incosciente possessore. Per la stessa ragione, non c’è differenza tra coltivare una nuova amicizia e leggere Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Il sé che si riflette in quest’opera risulta a tal punto estraneo che si ha l’impressione di dover scendere a patti con lui.

La letteratura non è un arte fatta dagli uomini per gli uomini, ma è il metodo degli uomini per essere tali e, in generale, diventare ed infine essere ciò che sono. È una ricerca, in altri termini, il cui fine è tuttavia insignificante, perché la ricerca è già essa stessa la massima rivelazione, che è poi una corrispondenza, a cui si può invero aspirare. Marcel Proust, che non a caso ha dedicato la vita a una recherche, era d’altra parte convinto che ogni lettore, nel momento in cui legge, non fa altro che leggere se stesso. Decidere se un simile circolo sia vizioso o virtuoso non sarebbe granché utile: è ben più interessante sapere che tale appunto è, un circolo, un’andata e un ritorno, la cui destinazione è e sarà sempre il suo punto di partenza – il lettore.
La letteratura è anzitutto una relazione, si è detto, e per mezzo di essa si entra dunque in rapporto con un sé che è un altro – come direbbe Rimbaud. Solo così può essere, infine, autentica rivelazione: perché si instaura una relazione con ciò che il lettore è, con ciò che può essere, sarà, non sarà mai. Ogni pagina, in questo senso, è riflettente. Cosa poi effettivamente rifletta non può che dipendere dal lettore stesso. Dire che due o più persone abbiano letto lo stesso romanzo non è che una scurrile semplificazione per dire che due o più persone hanno acquistato lo stesso prodotto. Ma non vi è modo che leggano lo stesso. Il riflesso di questa o quest’altra opera non può essere identico, a meno che non siano identici i lettori.
Michail Bachtin ha scritto che “il romanzo è l’unico genere letterario in divenire e ancora incompiuto”. Senz’altro, si vuole aggiungere, dal momento che il lettore è, per definizione, in divenire e incompiuto, e il romanzo è di lui trasposizione e riflesso.
Se il romanzo e in generale la letteratura sono in realtà una superficie riflettente in cui il lettore si specchia, le rivelazioni a cui quest’ultimo avrà accesso non potranno che essere parziali e sfuggenti. La letteratura è scoperta, indicazione e simbolo – ma non può essere risposta. Infatti, quel che abbiamo chiamato rivelazione, come a suggerire l’annuncio o la formulazione di una grande verità la quale, per mezzo della lettura, diviene accessibile, è invece più simile alla formulazione di una domanda. La letteratura, più che svelare i misteri, li formula – ciò che effettivamente rivela è analogo all’eco di una profondità. È una rottura, una crepa (riflessa e riflettente), attraverso la quale il lettore potrà andare in cerca di sé. Non costruisce, ma decostruisce, nel senso pregnante del termine, in modo che quell’umano di cui pare fare le veci possa discendere, ed annegare pure – se vuole – in quell’umano che è. La lettura apre una voragine tra ciò che il lettore è e ciò che vede di sé nel riflesso della letteratura. La discrepanza tra sé e il riflesso del sé è, d’altro canto, essa stessa la rivelazione.
La letteratura deve rivelare, riflettere e, riflettendo, dare le vertigini. Queste sono le condizioni per distinguere, e riconoscere se ciò che si legge è arte oppure qualcos’altro. S’intende, un libro può essere tante altre cose e godere di altrettanti motivi, finalità, ideali. Palatium è però nata per assistere a grandi rivelazioni, e sfamarne, per così dire, la voragine. Nient’altro. Tutto il resto – si deve ammettere – non ci interessa.